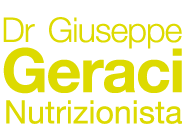Fare trekking nella provincia di Enna mi regala sempre grandi spunti. Questa volta mi ha fatto riflettere su un legume tipico della terra siciliana: le fave.
Molto presente in molte ricette della cucina tradizionale, Leonforte, comune della provincia ennese, è persino presidio Slow Food della fava larga, chiamata così per il sapore unico e le dimensioni più grandi rispetto ad altre tipologie (la fava di Ustica e la Cottoia di Modica per esempio).
La raccolta delle fave, seminate a novembre, è adesso, nel periodo primaverile.
In campagna, offre notevoli vantaggi poiché oltre a darci i baccelli freschi da mangiare, arricchisce di azoto il terreno, rendendolo così più fertile.
I semi delle fave sono contenuti dentro i baccelli, lunghi circa 10-15 cm. È un legume originario delle regioni mediterranee consumato fin dall’antichità. Già gli egizi, ma anche i greci e i romani, ne apprezzavano le proprietà nutrizionali.
Però, pur essendo molto nutriente, non era un alimento visto di buon occhio da tutti; spesso le fave venivano collegate in qualche modo ai morti.
Ancora oggi, in diverse località italiane, c’è la tradizione di consumare una zuppa di fave nei primi giorni di novembre, vale a dire nei giorni dedicati al ricordo dei defunti. La motivazione di questa diffidenza riguarda però un aspetto meramente “scientifico”: il deficit dell’enzima G6PDH, cioè un’anomalia genetica diffusa nell’Italia meridionale e nelle Isole, meglio nota con il termine favismo.
In pratica, nei casi di esposizione alle fave, tale malattia provoca la parziale distruzione dei globuli rossi con crisi emolitica; nei casi più gravi, bisogna persino fare delle trasfusioni di sangue.
La sintomatologia del favismo può presentare anche forme lievi. La cosa importante è eliminare le fave in tutte le forme possibili: come cibo, come inalanti (pollini), al contatto.
Una volta confermata tale condizione, insieme alle fave, dovranno essere esclusi anche altri legumi, come i piselli.
Come consumarla
La fava fresca si può consumare anche cruda come spuntino poco calorico ma che soddisfa il senso di sazietà, assai utile per chi vuole mantenere la linea (basti pensare che ci sono solo 37 kcal in 100 grammi di fave fresche).
Con le fave fresche cotte si possono realizzare ricette molto appetitose che, accompagnate con pane, riso o altri cereali, costituiscono un piatto nutrizionalmente completo.
Le fave secche, soprattutto quelle decorticate, cioè senza la buccia, sono impiegate per realizzare il famoso maccu (purea di fave).
In altre zone della provincia di Messina, come S. Agata di Militello e nelle zone limitrofe dei Nebrodi, è d’uso consumarla con tutto il baccello, specialmente se si tratta delle fave più tenere (le prime). Dopo averle lavate ed eliminate le punte, con un coltellino si toglie il ‘filo’ dai bordi dei baccelli che poi andranno lessati e consumati come fossero foglie di insalata, con aromi freschi e arricchiti con provola sminuzzata.
Caratteristiche nutrizionali
Ottimo contenuto di proteine e di fibre. Assenza di colesterolo che conferisce alla fava (come del resto a tutti i legumi) un ruolo indispensabile in una dieta equilibrata, adatta a garantire salute, vitalità e riduzione di rischio cardiovascolare e di molte patologie (diabete, diversi tumori). Sono una fonte preziosa di sali minerali (ferro, potassio, fosforo, calcio, sodio, magnesio, rame, selenio) e di vitamine (A, B, C, E, K, PP, niacina).
Come si traduce la parole “fave”
Data la pericolosità per chi soffre di favismo, ecco un mio elenco della parole “fave” in altre lingue. Avremo quindi: BAKLA (turco), DICKE BOHNEN (tedesco), HABA (spagnolo), BROAD BEAN (inglese), KOUKIA (greco), FÈVES (francese), POLLE (ebraico), TZAN-DOO (cinese), FOOLE (arabo).
Inoltre, nelle zone in cui risiede un soggetto affetto da favismo certificato, il comune di competenza emette un’ordinanza di revoca e restrizione per la coltivazione e vendita di fave e piselli. Ecco perché a volte, fuori dai supermercati, vengono esposti dei cartelli che indicano la presenza di fave all’interno dei locali.
Ed ecco la mia ricetta per voi: il Maccu di Fave
Ingredienti: fave secche siciliane oppure fresche + le sole foglie delle bietole + qualche foglia di alloro secco + sale marino + olio di uliveto.
Procedimento
Mettere a bagno la sera prima i semi delle fave secche intere, portare a bollore, spegnere il fuoco e aggiungere 1 cucchiaino di Bicarbonato alimentare. Lasciate in ammollo tutta la notte, l’indomani con un coltellino togliere l’ilo, conosciuto come occhio della fava o “pizzichedda” e spremete la fava per farla uscire da tutta la pellicina esterna (le fave vengono munnati du’ voti, cioè sbucciate due volte: prima tolte dal baccello e poi private della loro pellicina). Passaggio da saltare nel caso utilizziate le fave fresche.
Riponetele in un tegame pieno d’acqua salata, unitamente alle sole foglie delle biete e qualche foglia di alloro. Cuocete a fuoco lento per circa 40 minuti o fino a completa cottura (i legumi si devono poter schiacciare). Scolateli, lasciateli raffreddare, infine pestateli o frullateli fino a farle diventare una purea, condite con olio Evo.
Consumate con del buon pane cotto nel forno a legna, meglio se del giorno prima.
Curiosità
A Raffadali nella provincia di Agrigento, in occasione della Festa della Madonna del Rosario, il primo fine settimana di ottobre, viene organizzata la “Sagra del Macco”: Raffadali è, infatti, u paisi do maccu, cioè il luogo in cui questa pietanza ha avuto origine.